
di Giulia Elia*
Elenco sparso e incompleto di alcune delle esperienze vissute in questo mese.
Festeggiare questo inizio con una cena fuori e del vino bianco.
Rendersi conto di dover eliminare un bel po’ di quanto avevi scritto.
Dover trovare la quadra, capire su cosa puntare.
Dissipare i primi dubbi sulla storia che abbiamo scelto di approfondire: facciamola.
Immaginare LA domanda del mio pezzo.
Chiedere pareri.

Sentire il peso del compagno di lavoro che mi manca. Trovarne diversi sulla strada per ogni momento dell’inchiesta, come nella vita.
Aggiustare il tiro: come far diventare il progetto più inchiesta e meno affresco? Follow the money. Sarà un po’ spy story e un po’ più inchiesta: bellissimo, ma a riuscirci…
Chiedere autorizzazioni e non averle.
Andare in Rai Teche e non trovare ciò che cerchi.
Fare domande e non ricevere risposte.
Essere ignorata, con ostinazione.
Gli impegni che saltano.
Adattarsi agli altri, anche se di solito quella intransigente sono io.

Darsi una truccatina prima delle interviste per non dimostrare 15 anni, almeno con i medici.
Oscillare tra i mood: “La mia inchiesta è una bomba”, e “Non ce la farò mai, sto già indietro alla prima settimana di lavoro; o alla quarta”.
Fare telefonate, riguardare il girato, immaginare il montaggio, domandarmi come farò a coprire quei tagli impossibili ma necessari.
Mettersi in posizione d’ascolto.
Scoprire i propri pregiudizi, passarli in rassegna, provare a distruggerli; o almeno accantonarli per il tempo dell’intervista.
Imparare.
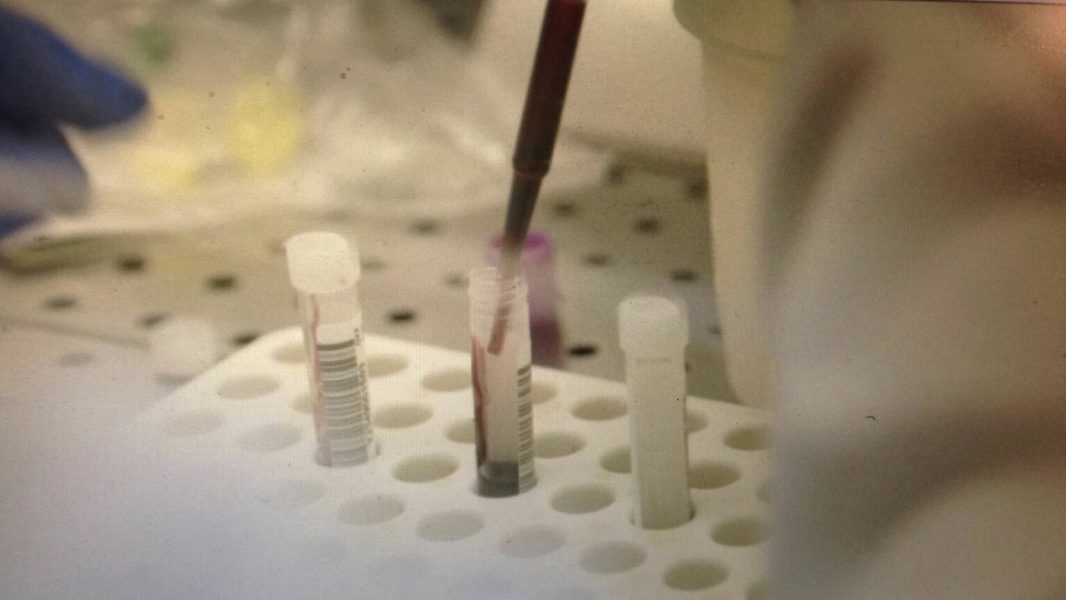
Riflettere sul fatto che quello che ci fa paura è più l’idea di qualcosa che non la cosa stessa: l’idea della malattia, più che la malattia.
“Ho trovato la canzone per Lui”: l’icona, l’essere umano non umano, il bugiardo che – non ti lasceremo mai vincere, tutto quello che fai è peccato: nessuno ti crede –
Farsi piacevolmente sorprendere quando quello che ti dicono è l’opposto di ciò che ti aspettavi.
Trovare empatia. O non trovarla.
Wuthering Heights.
Una trasferta di sole a Milano.
Puntualmente dopo ogni intervista realizzare la domanda che potevi fare e non hai fatto. La ripresa che non dovevi fare e hai fatto.
Ripromettersi ogni volta di far meglio. Buona la prima: per forza.
Vedere i tuoi piani deviare. Disattendere i programmi. Cambiare.
La camera sempre accesa, perché non si sa mai.
Mordermi la lingua con fastidiosa sofferenza. Intuire che in questo lavoro non sempre si può dire quello che si pensa.
Fare più attenzione. Immagini, coperture, piani d’ascolto, l’audio, com’è?
Riempire taccuini, per poi dimenticarseli a casa degli intervistati.
Quando ti presenti al più piccolo di loro,12 anni, che dopo il tempo di un paio di frame di imbarazzo ti abbraccia emozionato, annullando la distanza tutta formale che le presentazioni e i ruoli creano fra noi; meno male che è più maturo di me, e ci pensa lui a mettermi a mio agio.
Andare a prendere la microcamera: c’è qualcuno che si è offerto di prestarmela senza chiedermi nulla in cambio.
Come mi hanno detto dopo un’intervista, l’essere umano è così meraviglioso. “-Tu sei un budda così come sei-. Realizzare questo è destabilizzante. Ho pensato: -Wow, ma allora davvero posso vivere senza il senso di colpa?-“.
*finalista della sesta edizione del Premio Morrione con il progetto di video inchiesta “Tabù HIV”.







